Sega
Il titolo di questo capitolo non si riferisce allo strumento principe del falegname, né agli incapaci o agli inetti, o a chissà quale altra cosa che in questo momento non ho ben presente.
Qui si parla invece delle assenze (seghe), diciamo facoltative, dello studente dall’obbligo della frequentazione scolastica.
Voglio qui enunciare un mio personale principio, per me fondamentale, in base al quale lo studente è un individuo socialmente libero, politicamente rivoluzionario, economicamente mantenuto (i più bravi sono degli splendidi parassiti) ma eternamente squattrinato, intellettualmente e sessualmente fantasioso. La sua attività principale, da cui deriva il suo nome, è notoriamente pesante, noiosa, faticosa e fonte di frequenti stress, ed è quindi estremamente difficile e raro affezionarsi agli argomenti amorevolmente esposti dai professori. Se ciò avviene, egli, di fronte ai suoi simili, perde l’appellativo di “studente” per prenderne altri meno nobili, come “secchione”, “capoccione”, ed altri ancora meno nobili ma più coloriti ed efficaci secondo il dialetto usato.
Per questo, l’assenza facoltativa dalla scuola è uno dei bisogni primari del vero studente, che periodicamente deve necessariamente essere soddisfatto per mantenere un equilibrio accettabile tra doveri e piaceri.
In altri tempi si diceva “marinare” la scuola, come se i marinai, notoriamente poco attendibili per promesse e fedeltà, fossero quelli che maggiormente si assentano dalle lezioni. Un po’ come i turchi che battono tutti in quanto a fumo. Tuttavia, da parecchi anni non si usa più dire “marinare”, anche perché Guido Gozzano e il libro “Cuore” non sono più tanto di moda.
Ma quali sono le cause scatenanti della “sega”? Direi tantissime, e possono andare dalla paura di un’interrogazione o di un compito in classe, all’uscita con la ragazza o il ragazzo (oggi “partner”), una partita di qualunque cosa con gli amici, o più semplicemente per una umanissima mancanza di voglia.
Presa la decisione di far “sega”, lo studente deve però preoccuparsi di presentare, al suo ritorno a scuola, una giustificazione scritta e firmata da uno dei genitori o di “chi ne fa le veci”, come riportato fin dalla notte dei tempi sui moduli scolastici prestampati.
Ma come si fa a farsi firmare dai genitori e dalla segreteria dell’Istituto una giustificazione “ingiustificabile”? Basta allenarsi un po’ ad imitare le firme necessarie, ed il gioco è fatto. L’allenamento consisteva nel ripetere le firme qualche decina di volta, “facendo” la mano soprattutto con quella del responsabile della segreteria. Infatti, se qualche imperfezione nelle firme dei genitori era accettabile per i professori – eravamo veramente tanti per ciascun insegnante – quella del segretario era una sola e conosciuta da tutti, e quindi doveva essere perfetta.
I compagni meno bravi a fare i “falsari” spesso ricorrevano alle prestazioni dei compagni più “professionali”, i quali si allenavano periodicamente per garantire un… prodotto di alta qualità. Il compenso, se richiesto, poteva essere una sigaretta o qualcosa da mangiare. Prezzi modici, quindi.
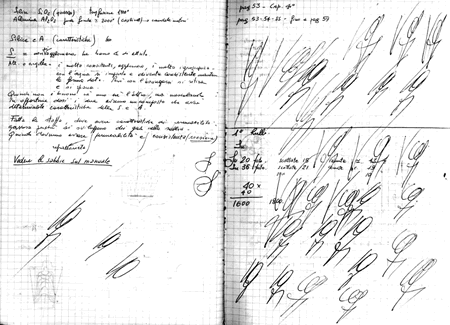
Un quaderno con gli “allenamenti” per la firma del segretario
Raramente la “sega” poteva essere generale, o come piace dire da qualche tempo, globale.
Come quel giorno in cui il 5° CB si assentò come un sol uomo. Ne ho dimenticato il motivo, semmai ce ne fu uno. Tuttavia, dopo qualche esitazione, a qualcuno venne in mente una brillantissima, geniale idea. Anche sull’autore ho una lacuna di memoria, anche se gli “orchestratori” delle nostre attività extra-scolastiche erano più o meno sempre i soliti.
Qui occorre una piccola premessa. Eravamo sì un po’ birboni, come del resto tutti gli studenti, ma avevamo tutti ricevuto in famiglia un’educazione ricca di principi sociali ed etici. Potevamo falsificare, per necessità, le firme dei genitori e dei dirigenti scolastici, e fare qualche pierinata come quelle descritte in questo testo, ma la nostra indiscutibile integrità morale non ci avrebbe mai consentito da adulti di legalizzare, per esempio, un falso in bilancio o altre inezie del genere.
L’idea era questa: saremmo stati assenti dal nostro “Galilei”, ma avremmo comunque seguito le lezioni. Magari in un'altra scuola.
Il “piano” prevedeva che saremmo entrati tranquilli e sereni nell’altra scuola insieme con gli studenti “veri” all’ora di apertura. Quindi, ci saremmo seduti compostamente in un’aula vuota o semivuota, che le nostre “avanguardie” avrebbero dovuto individuare nel più breve tempo possibile e senza dare nell’occhio. Poi, avremmo atteso gli eventi. Bello, no?
La scelta cadde sul vicino Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” in via di S. Croce in Gerusalemme, con appetibili classi miste e quindi ottimo per le nostre aspettative.
Perciò, raggiungemmo l’ingresso e ci mescolammo sul marciapiede agli studenti “veri”, cercando di assumere un contegno adatto al luogo e alla circostanza. Anche i dialoghi erano adeguati al contesto: scimmiottando i “veri”, parlavamo di materie per noi completamente sconosciute e avulse.
Quando la campanella dell’ingresso suonò, ci avviammo compostamente verso l’ingresso. Superato l’androne, in base ad un accordo prestabilito, salimmo le scale a coppie e tenendoci per la mano, come i bravi bambini dell’asilo. Fin qui, non molti degli studenti “veri” notarono l’intrusione, ma noi ci stavamo già divertendo.
Le “avanguardie” avevano subito trovato un’aula deserta, che prontamente occupammo. Il piano stava funzionando alla perfezione. Trattenendo a stento l’inevitabile ilarità, attendemmo che succedesse qualcosa.
Non si dovette aspettare molto tempo per far arrivare i titolari dell’aula, ovviamente sorpresi nel trovare i banchi quasi tutti già occupati, con le nostre ridenti faccine che guardavano le loro piuttosto stupite.
“Ma voi…. di che classe siete?”
“Quinta CB!” Rispondemmo noi quasi in coro.
“Quinta che?!”
“CB!”
La misteriosa sigla aprì una breccia nella loro testa.
“Ma…. non esiste la sezione CB! Che…”
“E’ che la scuola nostra è annata a foco! E allora semo venuti qua!”
Qualcuno degli “sfrattati” capì lo scherzo, noi ridevamo e loro quasi pure. Qualcun altro non capì, o non volle capire, e chiamò i soccorsi.
“Bidellooo! Professoressaaa!”
Magari sperando in chissà quale esemplare punizione per gli invasori. Invece arrivò una signora, non si sa in quale veste, e ci esortò, tutto sommato bonariamente, a liberare l’aula e a ritornare alla nostra scuola, cosa alla quale, ovviamente, non pensavamo minimamente.
Il resto della mattinata, come potete immaginare, lo passammo a commentare allegramente i fatti nel retro del Caffè-Pasticceria “Termini”, con le personali e fantasiose impressioni sulle ragazze di quella scuola.
Altre occasioni di esodi collettivi furono offerte dagli scioperi studenteschi. Sull’onda del maggio parigino e delle rivolte nelle università americane del 1968 tutta l’Europa e gran parte del mondo furono percorse da ondate di manifestazioni di protesta, occupazioni di scuole e università, scontri con le forze dell’ordine e le fazioni di colore avverso.
Non voglio qui parlare di quel periodo e delle conseguenze successive, ci vorrebbe troppo tempo, non ho la preparazione necessaria e poi non porterei niente di nuovo a quanto già detto e fatto. Come direbbe Antonello Venditti, “manca l’analisi e non c’ho l’elmetto”.
Però, visto che tutti dicono di tutto, anch’io vorrei dire qualcosa sul ’68.
A chi dice che ha fatto solo dei danni, rispondo che non è vero, perché finalmente la società moderna dovette scuotersi da quel torpore pieno di certezze in cui aveva vissuto finora. Molti tabù, annidati da sempre nell’animo umano, vennero denunciati e finalmente inclusi tra le cose normali della vita. D’altra parte, fino a quel momento moltissimi borghesi benpensanti vivevano segretamente di vizi e pubblicamente di virtù. Finalmente si cominciò a poter dubitare della rettitudine di autorità, capi, notabili e perfino dei genitori.
A chi dice che ha fatto solo del bene, rispondo che non è vero, perché nei decenni seguenti si è tentato spesso di copiarne lo spirito in circostanze incongruenti. Il ’68 era fortemente legato a quel momento storico, politico, economico e sociale. C’era una guerra lontana per la prima volta odiata da tutti, le prime avvisaglie di imminenti crisi petrolifere, l’innovazione mediatica della televisione, crisi economiche serpeggianti qui e là dopo gli anni del boom, la crescita del livello culturale medio, e altri fattori catalizzanti. I tentativi di “applicare” il ’68, quel ’68, in situazioni troppo diverse nei tempi successivi è stata una pretesa spesso priva di basi concrete. Forse anche noi genitori abbiamo sbagliato qualche volta nei rapporti “sessantottini” con i nostri figli.
Ma a noi del 5° CB, non ancora consapevoli di vivere un momento storico, gli scioperi e i cortei di protesta interessavano principalmente per due motivi: assentarsi da scuola praticamente in modo legale, cioè senza dover preparare alcuna giustificazione, e fraternizzare con le altre scuole in sciopero, preferibilmente femminili o miste.
Più spesso la “sega” era individuale o in gruppetti di almeno due o tre.
Come una volta, quando mi accodai ad una “sega” di gruppo con Flavio Benincasa, Guido Mazzeo e, se la memoria non mi tradisce, Lucio Steffè.
Era una giornata buia e tempestosa…. No, non è l’inizio di una storiella d’appendice, ma era veramente buio in pieno giorno e pioveva di santa ragione. Il Benincasa, già maggiorenne e patentato, aveva a disposizione l’auto del padre, una Fiat 1100 “Bauletto” (dei primi anni ’50) di un nero serio serio.
Salimmo in macchina e l’autista cominciò a girare nei dintorni del “Galilei”. Ad un certo punto disse ai suoi silenziosi passeggeri, con un tono intrigante:
“A’ rega’, devo rimedia’ quarche sòrdo. Devo trova’ uno che me tampona…”.
Con questa frase, e con l’aggiunta del tempo pessimo, nell’abitacolo si creò un atmosfera che faceva tanto Chicago anni ’20. Mi sembrava di trovarmi all’improvviso in uno di quei film dove una banda di gangster nella notte piovosa, in un silenzio tombale rotto soltanto dal ronzio del motore e dal cigolio del tergicristallo, si accingeva a fare il “colpo”. Stravaccati sui sedili con l’aria da duri, ci mancavano solo i cappelli alla Borsalino, i mitra e qualche sigaro fumante.
Il “capo” guidava con furbesca circospezione, cercando nello specchietto il potenziale tamponatore. Non appena individuò quello che sembrava buono, proprio di lato al “Galilei” su viale Manzoni, ci avvisò in modo consono al suo ruolo:
“Rega’, teneteve forte. Mo’ tiro er freno a mano…”
Il piano astutamente messo in atto dal “capo” consisteva nel frenare improvvisamente la macchina senza accendere le luci degli “stop”, ingannando così quello che seguiva. Mancando il rispetto della distanza di sicurezza e l’accensione delle luci il botto era garantito. E l’indennizzo pecuniario pure.
Perciò, la “gang” si irrigidì appiattendosi sugli schienali per attutire l’imminente contraccolpo.
Il “capo”, manovrando mirabilmente la vettura con la mano sinistra sul volante, la destra sul freno a mano, un occhio alla strada e l’altro sullo specchietto, calcolò il momento giusto, e tirò improvvisamente il freno a mano con l’inconfondibile crepitio:
“Craaaaaaac!….”
Al quale seguì il contraccolpo previsto, ma inaspettatamente in senso contrario, cosi che la “gang” dovette puntare precipitosamente braccia e gambe in avanti.
Che cosa era successo?
Nella realizzazione del “piano” non si era tenuto conto di alcuni fattori tipicamente italiani. L’auto a disposizione non era una “Buick”, né una “Oldsmobile” o “Ford” americane, di quelle usate dai veri gangster. Era una dignitosissima Fiat 1100 “Bauletto”, tenuta in ottime condizioni di efficienza, ma pur sempre una Fiat, e per di più “1100”. L’unica cosa in comune con le famose auto americane era solo il colore, il nero. Tutti, compresi coloro che non sono esperti di automobili, sanno perfettamente che le Fiat, specialmente quelle costruite fino agli anni ’60, non erano molto brillanti per motori, tenuta di strada e freni. I motori erano proverbialmente indistruttibili, ma i freni erano piuttosto addormentati e la tenuta prevedibile come un’estrazione del lotto. Ad aggravare la situazione, c’era anche la strada resa viscida dalla pioggia. Una macchina del genere in quelle condizioni è come una slitta sul sapone.
Con tali premesse si intuisce facilmente che l’idea di arrestare improvvisamente il “1100” con il solo freno a mano era parecchio fantasiosa. Ed infatti la manovra del Benincasa fallì miseramente: la macchina non solo non si fermò, ma poco mancò all’urto con quella che era davanti.
Solo una fortunosa affondata sul freno a pedale, accompagnata da un inevitabile “’rtaaaacci!….” evitò di passare da “tamponati” a “tamponatori”.
Così, da quasi gang di Al Capone diventammo in un amen la brutta copia della indimenticabile banda scalcinata del film “Audace colpo dei soliti ignoti”, dove Benincasa era una specie di “Piede Amaro” e gli altri qualcosa come Capannelle, Ferry Botte e compagni.
Mi pare di ricordare che la “banda”, povera come prima, andò a consolarsi con un cornetto al Caffè-Pasticceria “Termini” a via Conte Verde, che era il luogo di ritrovo abituale del 5° CB, quasi una specie di “covo”.
Era questo uno dei posti situati nei dintorni del “Galilei” dove ci si incontrava prima, durante o dopo l’orario di scuola. Un altro era un piccolo locale seminterrato su via Conte Verde proprio all’angolo con via Bixio dove, scendendo pochi gradini, si accedeva ai due biliardi del piccolo “Circolo Esquilino” (mi sembra questo il nome). Qui si esercitava la nobile arte delle boccette e della carambola, in un’atmosfera ovviamente pregna di fumo di sigarette fin dalla prima mattina. Per il dopo lezioni c’era la famosa rosticceria “Pizza e Polli”, vicino all’angolo di viale Manzoni con via di S. Croce in Gerusalemme; ma questo era un locale più di transito che di stazionamento, dove consumavamo rapidamente un boccone, possibilmente gratis…
Il Caffè-Pasticceria “Termini”, situato su via di S. Croce in Gerusalemme quasi a metà tra viale Manzoni e via Statilia, era il posto ideale dove incontrarsi la mattina presto per gustare uno dei suoi ottimi cornetti prima di entrare a scuola e, magari, per restarci o tornarci in caso di “sega”. La sosta era infatti qui resa confortevole da un paio di tavolini e da qualche sedia in fondo al locale dove, dopo il cornetto, si poteva tranquillamente giocare a carte. La clientela della pasticceria era più che altro di passaggio, comprava e se ne andava, e quindi il proprietario ci lasciava tranquilli al tavolo senza problemi, purché non facessimo troppa “caciara”.
Non sapendo dove altro andare, facevamo insomma un po’ come i “vitelloni” del famoso film felliniano. Ogni tanto qualcuno si alzava per andare a prendere una boccata d’aria fuori, buttare un paio di occhiate a qualche ragazza di passaggio (più che occhiate erano quasi delle “lastre”…), e poi si rientrava a giocare o a veder giocare a carte. Tutto qui. L’unica fatica era quella di far passare il tempo meno noiosamente possibile fino all’ora di fine orario. Poi ognuno tornava a casa sua.
Un giorno uggioso la pasticceria era piuttosto popolata da quelli del 5° CB impegnati in una “sega” numerosa. C’ero anch’io. Forse c’era qualche compito in classe, o comunque qualcosa da evitare, chissà. Fatto sta, che per quanti eravamo si dovevano fare i turni per giocare a carte.
Tra il pubblico presente c’era anche V.D.M., “lo sceriffo”, con il suo solito foulard fantasia annodato, guarda caso alla “cowboy”, intorno al collo. Questo foulard stava lì su quel collo da diversi anni, ormai faceva parte integrante del personaggio. Un V.D.M. senza foulard non l’aveva mai visto nessuno, nemmeno io che spesso andavo a suonare e a sentire musica a casa sua. V.D.M. stava assistendo alle partite con un’aria tra l’addormentato e il distratto, presente fisicamente ma non mentalmente.
Ad un certo punto Flavio Benincasa lo sveglia da quella specie di trance con una domanda secca:
“Ma quann’è che te fai stira’ ‘sto foulard tutto ciancicato?”
Per coloro digiuni di romanesco, chiarisco che “ciancicato” significa masticato, spiegazzato.
V.D.M., laconico come sempre, accenna un “Boh, mah”.
Ed ecco che allora il 5° CB, generoso e altruista come sempre, interviene per risolvere l’evidente problema del compagno.
“Damme ‘n po’ ‘sto foulard. Ce penso io!”
Così dicendo Flavio e Claudio Gargottich si fanno consegnare il foulard da V.D.M., che evidentemente stava al gioco.
Ma il ferro da stiro dove lo avrebbero trovato?
All’epoca in via di S. Croce in Gerusalemme transitavano i tram che collegavano la stazione Termini con la periferia. Come pochi sapranno, i tram hanno ruote di acciaio durissimo che camminano su rotaie di acciaio altrettanto duro, e sono parecchio pesanti. Quale ferro da stiro a freddo poteva essere migliore di un tram? Ed anche economico, a costo zero? L’idea astuta e quasi geniale era quella di far stirare il foulard dal primo tram di passaggio. D’altra parte, non stavamo studiando da Periti Industriali per caso.
Con il foulard da “stirare” partì un gruppetto che, con un magnifico lavoro di squadra (uno teneva il foulard e gli altri controllavano la strada per calcolare il momento buono), posò il vezzoso accessorio d’abbigliamento sulla parte piatta della rotaia e, voilà! il tram passa rumorosamente con le sue numerose ruote e lo stira perfettamente.
Oddio, perfettamente… Quando l’oggetto fu trionfalmente restituito al legittimo proprietario era sì stirato, ma un pochino lacero.
Fu così che, dal giorno dopo, vedemmo finalmente V.D.M. con un nuovo, fiammante e sgargiante foulard annodato sul collo. Naturalmente con colori e disegni ancora più impossibili di quello vecchio premurosamente “stirato”.
In seguito, non ci fu più tempo di ripetere la stiratura, perché finì la scuola e arrivò il tempo degli esami.
Già, gli esami di Stato. Fino a quel momento ci eravamo spesso divertiti, così bene che per me era una gioia andare a scuola.
La mattina, partivo da casa mia vicino a piazza dei Re di Roma e a piedi raggiungevo la scuola. Quando arrivavo all’inizio di via di S. Croce in Gerusalemme cominciavo a sentire odore di “Galilei” e di 5° CB, e allora mi chiedevo, pregustando la giornata, “che succederà oggi di bello?” e di solito non restavo deluso, c’era sempre qualche “performance” garantita.
Una mattina, appena sbucato su quella via e con quel pensiero in testa, mi vedo venire incontro tutto il 5° CB festante come non mai e con un bel pallone sotto il braccio di qualcuno.
“Che succede?” Chiedo al primo della “truppa”.
“Mancano cento giorni all’esame, famo tutti sega!”
Qualcuno aveva fatto un po’ di conti e aveva scoperto che mancavano giusto cento giorni agli esami di Stato, previsti per il primo di luglio. Perciò i fatti dovrebbero risalire all’ultima decade di marzo del 1970. In realtà, i conti si rivelarono sbagliati per difetto, e qualche giorno dopo l’assenza generale fu replicata, con grande soddisfazione di tutti.
Era una gran bella giornata primaverile, gradevole per il bel sole e la temperatura. Meglio di così non poteva capitare! Un giorno di libertà come poche volte capita nella vita.
Perciò, per quanto mi riguardava, feci un rapido dietro-front e con tutto il gruppone si andò dritti nel piazzale antistante la Basilica di S. Croce. Posati su una panchina cappotti e cartelle (non c’erano ancora gli zaini, li usavano solo i montanari), s’ingaggiò subito una partita a pallone nell’unico stile adatto alla circostanza, cioè alla “viva il parroco”.
Dopo la partitina, il gruppone si divise in tanti gruppetti, ognuno diretto dove più piaceva ai rispettivi componenti. Personalmente, andai con altri quattro o cinque sul pratarello inondato dal sole alla base delle Mura Castrensi, proprio alle spalle della Basilica. Non prima di essere passato a casa per lasciare l’inutile borsa e per prendere la mia fidata chitarra. Crogiolarsi al sole su un prato e suonare qualunque cosa ti passasse per la testa era una delle belle cose della vita che la mia generazione aveva scoperto. E così facemmo.
Credo che il sapore e le sensazioni di tutto questo appartenga a quel periodo, a quell’età, a quegli anni, e siano irripetibili. Qualunque tentativo di riprodurre certi momenti è destinato a scarso successo, se non al fallimento. Forse è giusto così. Le minestre riscaldate e i remake raramente hanno la bontà e la bellezza degli originali, che restano, concedetemelo, “opere” uniche. Lo dico per esperienza personale. Possono somigliare, ma non saranno mai come gli originali, che io porto sempre con me. E ogni tanto, come ora, li rivivo e li riassaporo.
Si stava veramente bene. Il sapore della “sega” collettiva in una splendida giornata di sole non ha uguali, è qualcosa di veramente buono e indimenticabile, certamente molto meglio di quelle passate al biliardo o nel retro della pasticceria “Termini”, oppure in strada quando il tempo è grigio e triste.
Il mio gruppetto era composto da diversi strimpellatori (sarebbe più adatto dire “straziatori”) di chitarra: oltre a me, c’era P. S. e V.D.M., con il quale già avevo fatto esperienze pluriennali di memorabili jam sessions a casa sua.
Cosa sono le jam sessions? Per chi non lo sapesse, dirò che pressappoco sono dei concerti eseguiti spontaneamente da pochi musicisti che iniziano a suonare su uno spunto, che può anche essere casuale, e svilupparsi a piacere anche per ore. Un po’ come la poesia a braccio: parte uno e gli altri vanno avanti a rotazione. Ovviamente, i generi musicali più adatti sono il jazz, il blues e il rock. Beethoven non ce lo vedo proprio impegnato in una cosa del genere, ma Mozart sì, matto com’era sarebbe andato benissimo.
Orbene, le nostre non avevano le pretese di essere jam sessions vere, ma facevamo del nostro meglio. Di solito due chitarre, un’armonica a bocca (suonata da uno che non era del 5° CB) e qualche bicchiere di quello buono bastavano. Col cervello lubrificato dal Chianti o dal Valpolicella e da qualche sigaretta, per quelli che come me stavano crescendo con i Beatles, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, i Pink Floyd e altri che non sto a dire, suonare a casaccio per qualche ora era piacevole. Per gli ascoltatori forse un po’ meno, ma noi eravamo contenti così.
Qualche volta abbiamo persino registrato le nostre performances con un registratore “Geloso” a nastro, comunemente noto come “Gelosino” e facilmente riconoscibile per i suoi tasti grandi e coloratissimi di rosso, giallo, blu, verde. Per l’epoca la qualità della registrazione era accettabile, ma sembrava proprio un giocattolo. Oggi non lo farebbe nemmeno la “Chicco”, risulterebbe sgradito anche al bambino più accomodante.
Quando ascoltavamo quello che avevamo suonato, stentavamo a riconoscerci. Sembrava l’opera di qualche alcolizzato in preda al mal di pancia, con quegli “yeah!.. yeah!…” che ogni tanto emettevamo per fare più “USA”. Però il “sound” c’era!
Così, quel giorno sul piccolo prato inondato dal sole iniziò, senza alcun preavviso, una piccola jam session. La chitarra passava di mano, ciascuno suonava quello che voleva, anche cose che non esistevano, ma sempre del genere rock o blues.
Sarà stata l’aria della primavera, il sole, la libertà, ma si andava a ruota libera che era una bellezza. La chitarra girava: rock e blues classico, qualche spunto psichedelico. Un relax stupendo.
Finché, ad un certo punto, tocca di nuovo a P. S., che si alza in piedi e attacca qualcosa di impetuoso, mi sembra “Johnny B. Goode”. Aveva cominciato a suonare e cantare come un forsennato, dimenandosi come i cantanti rock veri. Bene, bravo! Svegliato improvvisamente da quel torpore nel quale ero immerso, ammiro compiaciuto quel “matto” che ci dava dentro. P. S. ci provava evidentemente gusto in quello che stava facendo, era insomma entrato nella “parte”. Tanto che improvvisamente, senza smettere di seviziare la chitarra, si butta audacemente per terra e fa una piroetta degna del grande Chuck Berry. Qualcuno gli urla “Bravo!”, ma a me, in quanto proprietario della chitarra, si era gelato il sangue e drizzati i capelli, che all’epoca erano ancora numerosi sulla mia testa. Nell’acrobazia appena eseguita, l’impugnatura della mia beneamata chitarra era passata a mezzo centimetro da terra. Se P. S. non fosse stato così agile, io mi sarei ritrovato con una specie di mandolino, e lui con una cravatta di legno nuova nuova.
A distanza di tanti anni quella chitarra è ancora qui, la custodisco gelosamente, ma la voglio simbolicamente regalare a P. S.,. Prendendo in prestito una frase famosa, gli vorrei chiedere “Suonala ancora, P. S.,”.
di Luciano Calvani - 15/12/2005

Quest'opera è pubblicata sotto una licenza
Creative
Commons.